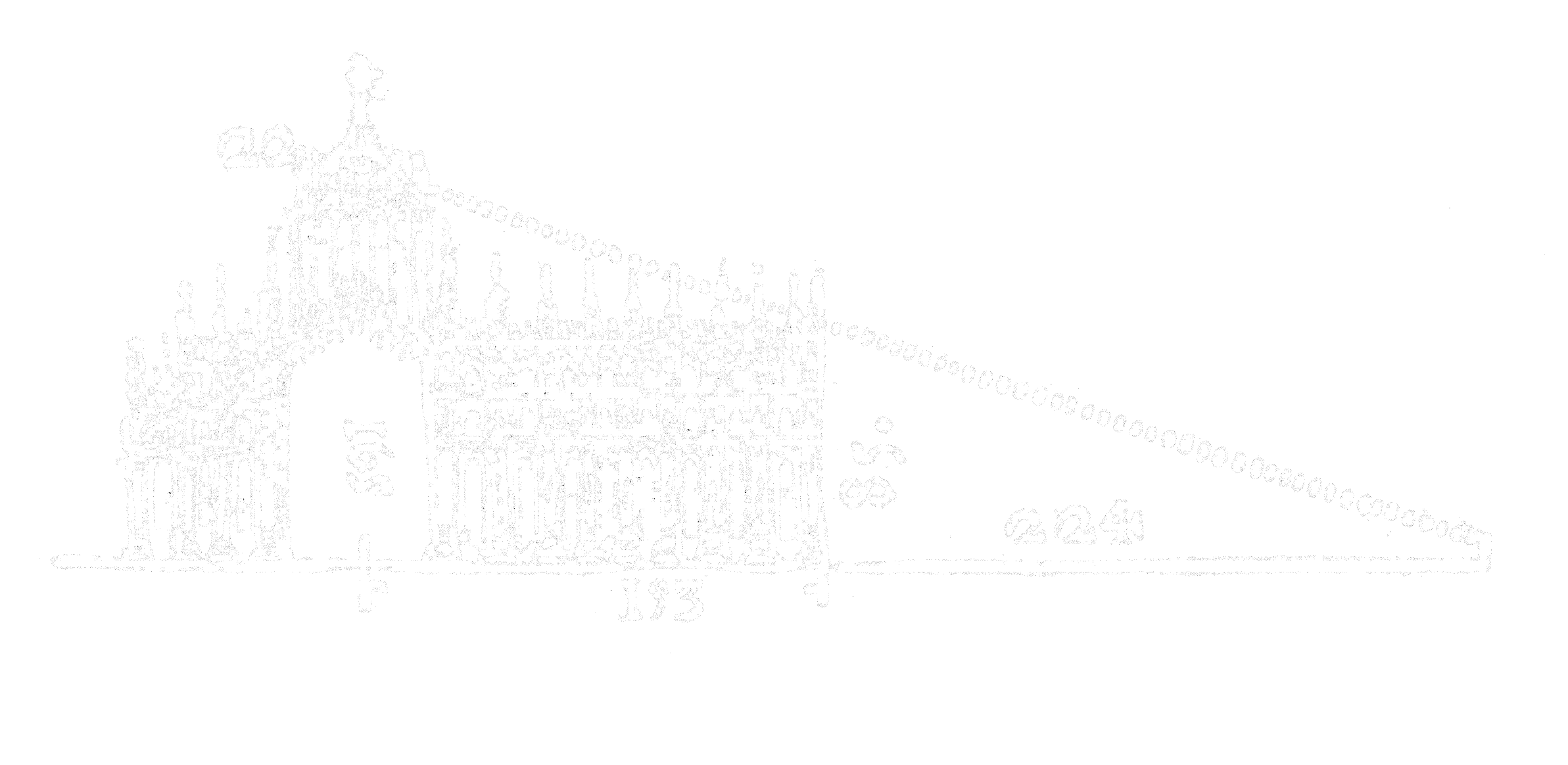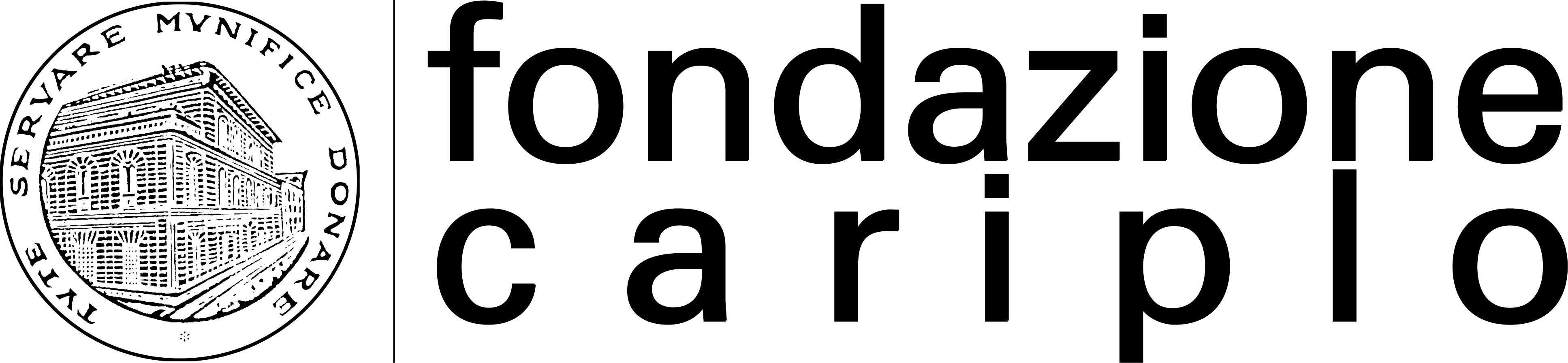Prospetto del transetto settentrionale
Autore
Seregni, VincenzoTitolo
Prospetto del transetto settentrionaleDatazione
XVI secolo; [1534-1567]
Collocazione
ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 14r
Dimensioni
1168x873 mmTecnica e Supporto
Preparazione a punta secca, largo uso di compasso; esecuzione a penna e inchiostro ocra; supporto cartaceo di media grammatura, filigrana non presente.
Scala
Non presenteIscrizioni
Sul verso, a penna e inchiostro bruno: «disegnio della porta del domo fatto per Vince[n]tio Segnio».
Sul verso, indicazione inventariale moderna, a matita: «TOMO II foglio 14 SP».
Sul verso, indicazione inventariale moderna, a matita: «2 14r».
Sul verso, a matita, due lettere (iniziali di un nome?) delle quali si legge bene solo la seconda: «[+] C».
Sul verso, indicazione inventariale antica, a penna e inchiostro nero, in parte cancellata: «12 [+] P».
Sul verso, timbro moderno a inchiostro blu dell’Archivio Storico Civico: tondo con al centro lo stemma del comune di Milano e l’iscrizione in lettere capitali «ARCHIVIO STORICO CIVICO».
Notizie
Il disegno rappresenta una delle testate del transetto del Duomo di Milano, presumibilmente quella settentrionale, tanto che l’elaborato è sempre stato inserito nel contesto delle discussioni per la porta verso Compedo, che è però assente dal disegno stesso, lasciata in bianco. Il foglio si trova all’interno del secondo tomo, interamente dedicato al Duomo, della Raccolta Bianconi, conservata oggi presso l’Archivio Storico Civico di Milano, composta in dieci volumi dall’architetto, collezionista e storico Carlo Bianconi tra il 1789 e il 1796 e contenente disegni di architettura e alcune incisioni rappresentanti edifici milanesi tra il XIV e il XVIII secolo. La storia del foglio si accompagna quindi con quella della Raccolta, che dopo essere passata ai Litta e poi ai Vallardi, entra nel 1872 nelle collezioni civiche milanesi, quando il Comune di Milano la acquista da Antonio Vallardi. Il disegno è l’unico presente al foglio 14r del tomo, che ha tra l’altro il verso lasciato libero, mentre è oggi visibile, sia il recto che il verso del disegno (presso l’Archivio Storico Civico esiste una riproduzione fotografica in bianco e nero del disegno, negativo A 4087).
Il disegno è composto su quattro fogli si dimensioni simili (530x420 mm circa) incollati insieme a formare un quadrato, disposti in verticale, due sopra e due sotto, e lievemente sovrapposti. Il foglio presenta tracce di molte piegature, dovute alle grandi dimensioni, in corrispondenza delle quali si sono prodotti nel tempo diversi strappi, colmati in parte sul verso mediante l’aggiunta di strisce di carta, alcune sembrano antiche. Sul verso compaiono anche numerose tracce di colla, alcune di un nastro adesivo poi rimosso, inoltre macchie brune, tra le quali una macchia piuttosto estesa, prodotta dal rovesciamento di una sostanza liquida e poi diverse macchie di inchiostro nero. Anche sul recto vi sono macchie di inchiostro nero e altre macchie brune, ma la superficie del foglio è globalmente ben conservata: evidente solo una piccola lacuna collocata circa al centro.
La preparazione a punta secca del disegno è condotta in modo assai accurato, interessa tutte le linee poi ripassate a penna, anche quelle più minute e ravvicinate ed eccede di pochissimo i bordi del disegno. La precisione della preparazione si denota anche nell’uso molto esteso del compasso, utilizzato anche per gli archetti, realizzati attraverso una serie di piccole circonferenze incise, sovrapposte nei casi degli archetti trilobi. Sono sempre evidenti anche i segni della costruzione geometrica, come per esempio le piccole linee di intersezione a X in corrispondenza dell’arcone ogivale centrale. Parimenti, molto abile e precisa è l’esecuzione a penna con inchiostro ocra eseguita tramite linee molto sottili e sicure nel tratto prevalentemente con strumenti, eccettuate alcune concessioni al disegno a mano libera, che interessano solo i particolari decorativi più minuti, come per esempio le punte dei pinnacoli e delle guglie e gli elementi floreali.
Il disegno non sembra però concluso, diverse linee sono interrotte a metà nella parte centrale, inoltre, la rappresentazione perfettamente ortogonale del prospetto provoca una difficoltà nella realizzazione delle cuspidi alla sommità della testata, dove quelle d’angolo sono risolte con il posizionamento di metà cuspide, lasciando in sospeso l’altra metà, ma talora mostrandone imprecisamente una parte, che quindi avanza in larghezza lo spigolo della cattedrale. Il disegno è realizzato con il solo uso della penna e non presenta ombreggiature, fuorché in alcuni particolari nei quali si nota un accenno di tratteggio obliquo singolo.
Note critiche
Il disegno rappresenta il prospetto ortogonale della testata del transetto della cattedrale, molto simile al costruito; sebbene non si configuri come un rilievo vero e proprio, non sia quotato e sia privo anche della scala dimensionale originaria, esso può ritenersi tale almeno per quanto concerne l’impostazione strutturale e anche le partiture decorative principali. Questo aspetto è valutabile anche da un confronto con la parte corrispondente del modello ligneo, che ne dà una versione lievemente semplificata nei particolari minuti, ma sempre molto vicina.
Abbiamo dunque nella parte inferiore il basamento che circonda tutta la cattedrale, sul quale si impostano i poderosi contrafforti che ritmano verticalmente le pareti, i due di spigolo del transetto, larghi il doppio di quelli che delimitano la campata centrale, ma decorati allo stesso modo, solo con un conseguente raddoppio delle specchiature, e con gli stessi elementi decorativi, a creare fasce orizzontali anch’esse comuni a tutti i prospetti del Duomo. Troviamo quindi un primo livello di doccioni, che hanno al di sotto il piccolo basamento pensile per le statue; un secondo livello al di sopra della quota dei finestroni, con la presenza di archetti con decorazioni floreali a coronamento delle specchiature dei contrafforti, sormontati da falconature cuspidate con archetti trilobi e gattoni nella parte superiore e la presenza di due slanciati pinnacoli alla sommità dei pilastri angolari stessi, più uno al centro del coronamento sommitale. Tra i contrafforti, le pareti arretrate delle campate hanno al centro due grandi finestroni archiacuti decorati a traforo, che si estendono in altezza dal basamento al livello degli archetti e, nella campata centrale, invece, un grande vuoto al di sotto dell’arcone ogivale, corrispondente alla sezione delle volte interne, nel quale manca la definizione del portale.
Gli studiosi, a partire da Beltrami (cfr. Beltrami, 1900), concordano nell’inserire il disegno all’interno dell’iter progettuale per la porta verso Compedo, sebbene sia evidente la sostanziale differenza con i progetti per la porta vera e propria, che concentrano l’attenzione solamente sulla campata centrale del transetto, che invece compare in questo foglio nella sua interezza. È stata in particolare Aurora Scotti a occuparsi della lettura critica del pezzo (Scotti, 1977; Scotti 1989) nell’ambito della produzione grafica di Vincenzo Seregni, dal momento che il disegno è di ,sicura paternità dell’architetto, del quale compare la firma sul verso. La studiosa ha posto inoltre il disegno in relazione con altri fogli, come il 6rA, anch’esso inserito nella Raccolta Bianconi, tomo secondo, che mostra un particolare dello spigolo della stessa testata (presumibilmente), nel quale sono rappresentati di fronte il basamento e il piccolo elemento verticale cuspidato collocato in angolo (visibile quindi di lato), con la presenza delle misure corrispondenti all’altezza degli elementi, nonché la pianta a filo di ferro della testata stessa, anch’essa corredata dalle misure, in braccia milanesi. La concomitanza di questi elementi farebbe pensare che il piccolo disegno 6rA rappresenti uno studio dimensionale di dettaglio, oppure un esecutivo, con un’evidente rispondenza al disegno di Seregni, che sarebbe quindi da collocare cronologicamente, secondo Scotti, negli anni della sua nomina ad architetto della Fabbrica e quindi intorno al 1547, corrispondendo inoltre a quanto era in corso di realizzazione in quegli anni per la testata settentrionale. Non è in realtà chiaro cosa fosse già stato realizzato, dal momento che proprio questo particolare compare anche in diversi altri progetti per la porta verso Compedo, anche precedenti di diversi anni, almeno alla fase progettuale della metà degli anni Trenta del XVI secolo, datazione che peraltro non inficerebbe l’eventuale presenza di Seregni, già attestato in cantiere nel 1535 (accompagna Cristoforo Lombardo alle cave di Candoglia). Il disegno è stato anche avvicinato dalla studiosa stessa a un’incisione, oggi irreperibile, ma riprodotta da Beltrami (Beltrami, 1900, p. 25) e conservata un tempo in unico esemplare presso la Biblioteca Ambrosiana (Beltrami ne riporta l’inventario, G.D.V. n. 48), che rappresentava la stessa testata del transetto. L’incisione costituiva l’intestazione di un foglio a stampa contente le Proposizioni di Seregni per la facciata maggiore del Duomo, sul quale stava anche la data 1537 (documento trascritto negli Annali dopo il 31 dicembre 1537: Annali, III, p. 267 e in particolare nota 1), inserendosi dunque pienamente nelle discussioni sulla porta verso Compedo, tornate attuali proprio in quel torno di anni. È stato spontaneo, quindi, per Beltrami segnalare in Seregni l’autore dell’invenzione alla base dell’incisione, ipotesi ragionevole, anche se non certa in modo assoluto. I dubbi su una datazione così alta sia per l’incisione, che conseguentemente per il foglio 14r della Bianconi, nascono tuttavia dalla considerazione della giovane età di Seregni alla metà degli anni Trenta del XVI secolo, che apparentemente contrasta con l’accuratezza tecnica e la sicurezza esecutiva di quest’ultimo (Scotti, 1977; anche se sono piuttosto carenti altre prove grafiche così precoci che consentirebbero certamente di poter meglio valutare questo aspetto). Tra le ipotesi formulate si trova quindi anche quella secondo cui i due elaborati sarebbero entrambi da spostare più avanti e che l’estensore degli Annali possa aver compiuto un errore di lettura, segnando il 1537 per il 1547, o addirittura il 1557 (Perossi, 1999-2000), ipotesi supportata con il fatto che nelle Proposizioni si parla di decisioni risolutive prese per la porta: «essendo cum optima ragione et a compimento parlato de la porta, visto li objetti e diucidato bene il tuto, d’onde a honore de la Maestà divina si è facta una optima conclusione» (Annali, III, p. 267; Scotti 1977, con riferimento alla delibera del 18 aprile 1547, nella quale si intima per l’ennesima volta a Cristoforo Lombardo di concludere il modello iniziato; Annali, III, p. 300). Dobbiamo rilevare tuttavia che l’espressione di Seregni si adatta in realtà a diverse situazioni, poiché anche nel 1537 erano state prese decisioni risolute, con la realizzazione del modello da parte di Cristoforo Lombardo e soprattutto la delibera per l’unicità dell’ingresso e per l’avvio dei lavori. Inoltre, resta da valutare per confronto un altro elaborato databile agli anni Trenta e realizzato dallo stesso Seregni per la porta verso Compedo, ovvero il disegno di cui consta copia del XIX secolo al foglio n. 247 dell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo. Se si dà credito all’iscrizione che accompagna la copia di questo progetto, infatti, se ne trae la data 1534 e se ne ricava quindi ulteriore prova di come l’architetto stesse ragionando sul problema anche in quegli anni.
Tutte queste considerazioni, seppure contribuiscono alla restituzione di un contesto storico per questo foglio, non giovano a una sua datazione specifica, soprattutto perché la vicinanza con l’incisione riprodotta da Beltrami in realtà è (come appare ovvio, data anche la differenza del mezzo esecutivo), puramente di soggetto, ovvero si nota una sostanziale affinità della struttura della testata, mentre l’incisione presenta una proposta per la soluzione della porta, che è assente dal disegno. L’unica certezza è che i due pezzi sembrano rappresentare nella sostanza lo stato di fatto della testata settentrionale, come facilmente desumibile, se non dal monumento stesso, almeno dal modello ligneo. Disponendo di un modello, perciò, i due pezzi potrebbero paradossalmente essere stati realizzati anche a molti anni di distanza e non essere in alcun modo tra loro correlati.
Il disegno del f. 14r della Bianconi resta dunque collocabile tra il 1534 (prime attestazioni di prove grafiche di Seregni per la porta verso Compedo) e addirittura i primi anni Sessanta, quando ancora Seregni si trovava impegnato nella vicenda della porta (si veda per esempio il documento del 1562, riferito alla concreta realizzazione di un pilastro della porta, per valutarne la riuscita rispetto al prosieguo della costruzione; 1562, 14 dicembre: Annali, IV, p. 50).
Più significative sembrano le puntuali considerazioni di Aurora Scotti (Scotti, 1977; Scotti, 1989) e Nicola Soldini (Soldini, 1999) rispetto alle qualità tecniche dell’elaborato grafico, soprattutto in valutazione del tipo di preparazione del foglio, che, come abbiamo visto, è costituita da un preciso tracciato regolare a punta secca, che non solo segna la guida per i tratti orizzontali e verticali, tutti poi realizzati a strumento, ma è estesa finanche alle linee ricurve più piccole, prassi più raramente applicata e che testimonia l’impiego di una tecnica di realizzazione altamente rigorosa. Questo tipo di modus operandi sembra essere piuttosto tipico per Seregni, poiché si riscontra con evidenza in altri disegni firmati o assegnabili al maestro con un discreto margine di certezza, come per esempio i ff. 13r e il 21v sempre nel secondo tomo della Raccolta Bianconi. Anche l’esecuzione, così meticolosa nel rispettare le linee incise e che non cede all’utilizzo di tratti a mano libera, ma si lascia guidare totalmente dallo strumento, sembra essere a parere di Aurora Scotti, non solo indice di una mano matura, ma anche di una riflessione sui modi di rappresentazione degli alzati. La studiosa individua in particolare nel rigore della preparazione incisa (del medesimo tipo di quelle che venivano impiegate per la realizzazione delle piante) un aiuto importante nel passaggio a prospetti totalmente ortogonali, che si differenziano per esempio da quelli assegnabili pochi anni prima a Cristoforo Lombardo, proprio per l’assenza di parti in prospettiva. Anche Nicola Soldini riflette in questi termini, ragionando sia sulla vicinanza dal punto di vista tecnico con il f. 15r della stessa Raccolta Bianconi, sia sugli aspetti formali che accomunano i due fogli, ovvero una ripresa del gotico inteso in modo tradizionale, ma in una lettura lineare, geometrica e puramente architettonica (e non scultorea; su questo anche Scotti, 1977), in linea con la tendenza già avviata da Cristoforo Lombardo, del quale Seregni, come è noto, fu stretto collaboratore proprio nel cantiere del Duomo.
È sempre Soldini dunque a ipotizzare, date le dimensioni, che il disegno potesse costituire una base sulla quale potevano essere montati i disegni per la porta, tuttavia non sono noti disegni, tra quelli sopravvissuti, che risultino a esso in scala. Certamente la natura del disegno, e ancor più la sua fedeltà al modello ligneo e ad altri elaborati, farebbe effettivamente pensare a una registrazione dello stato di fatto o almeno una rappresentazione della parte dell’edificio definita senza incertezze dal punto di vista formale, in modo da costituire un punto di partenza progettuale a disposizione dei maestri.
Bibliografia
L. Beltrami, La Porta Settentrionale nel Duomo di Milano (porta versus compedum). Vicende e raffronti con disegni inediti, Milano, 1900, p. 24
Luca Beltrami e il Duomo di Milano. Tutti gli scritti riguardanti la cattedrale pubblicati tra il 1881 e il 1914, a cura di A. Cassi Ramelli, Milano, 1964, p. 267
A. Scotti, Per un profilo dell’architettura milanese (1535-1565), in Omaggio a Tiziano. La cultura artistica milanese nell’età di Carlo V, catalogo della mostra, Milano, 1977, p. 106, nota 16; p. 118, n. 87, p. 119, fig. 87
A. Scotti Tosini, I disegni cinquecenteschi per il Duomo di Milano: Vincenzo Seregni nel tomo II della Raccolta Bianconi, in Il disegno di architettura, a cura di P. Carpeggiani, L. Patetta, atti del convegno (Milano, 1988), Milano, 1989, p. 158
I. Balestreri, I disegni del Duomo di Milano nella Raccolta Bianconi, “Il disegno di architettura”, 7, 1993, pp. 24, 27
La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manierismo al Barocco, a cura di I. Balestreri, Milano, 1995, p. 23
M.C. Loi, L’attività architettonica di Cristoforo Lombardo detto il Lombardino (anni 90 del ‘400-1555), dottorato di ricerca in storia dell’architettura, Università degli studi di Roma La Sapienza, 1996, II, p. 214, n. 29
F. Repishti, Vincenzo da Seregno nella cultura milanese del Cinquecento: cantieri, committenti, architetture, dottorato di ricerca in storia e critica dei beni architettonici e ambientali, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 1997, pp. 88-89, fig. 4
A. Scotti, N. Soldini, Scheda, in Il giovane Borromini. Dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fontane, a cura di M. Kahn Rossi, M. Franciolli, catalogo della mostra (Lugano, 1999), Milano, 1999, p. 124
S. Perossi, Il dibattito rinascimentale sulla Porta di Compedo del Duomo di Milano, tesi di laurea, relatore A. Rovetta, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1999-2000, pp. 250-255, n. 12